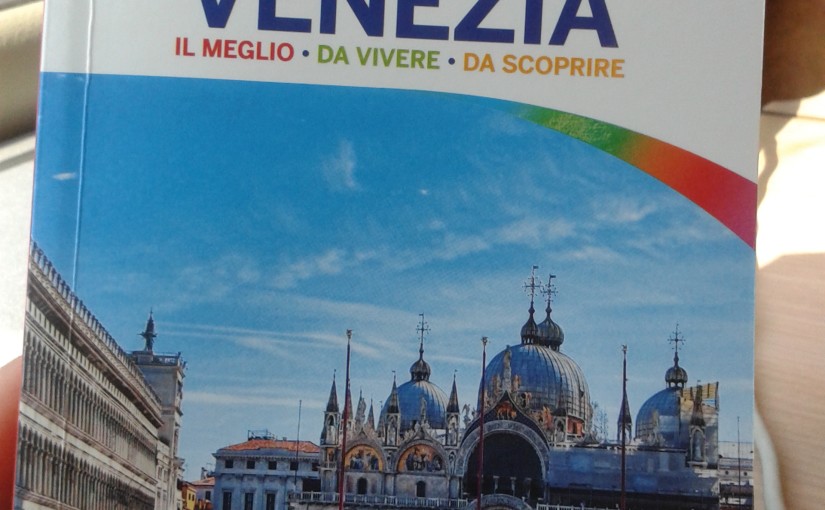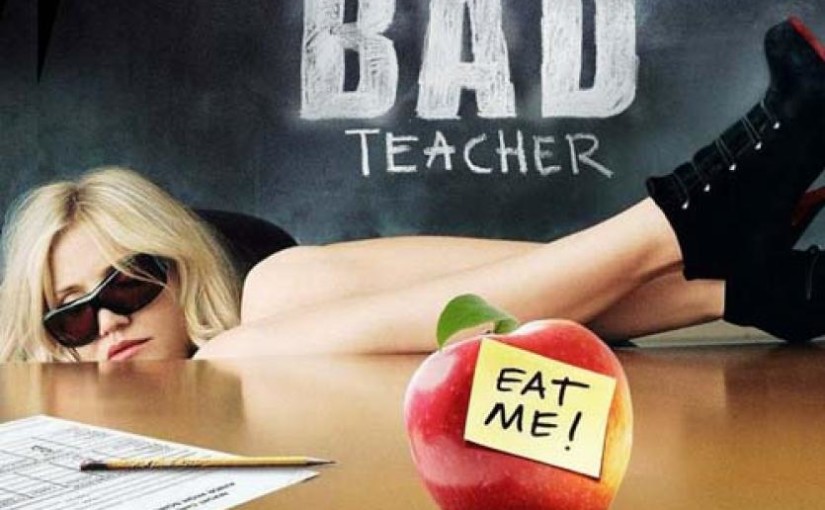Partire per le vacanze significa interrompere il flusso quotidiano e, letteralmente, sospendere l’attività.
L’esito di questa operazione può essere positivo, perché si stacca, ci si riposa, si recupera energia, si guardano le cose da fuori, ci si diverte, ma anche negativo, proprio perché vengono a mancare i riferimenti che ciascuno ha nella sua vita di tutti i giorni.
Se l’equilibrio personale è fragile, la vacanza può destabilizzare, portare i nodi al pettine, togliere sicurezza e seminare disordine nelle relazioni, perse nel tempo vuoto.
Proprio per questo, solitamente, la vacanza viene riempita di tutto ciò che può tenerci in piedi: sicurezze, punti di riferimento, attività come se fossero lavoro.
Lo sanno bene gli operatori turistici, chi organizza i tour, le crociere, i viaggi organizzati.
Il cliente, il turista, non deve sentirsi perso nel tempo nuovo e diverso che ha, ma circondato di elementi che lo facciano sentire bene.
Familiarità, cibo, movimento, orari prefissati, accudimento e custodia.
Tutto questo, se il viaggio è fai-da-te, viene cercato e definito da soli e la cosa interessante è accorgersene.
L’hotel, la casa in affitto, la roulotte o il bungalow che si affittano diventano casa nel momento in cui li riempiamo dei nostri oggetti. La mensola in bagno, il comodino, l’armadio, la cucina.
Il custode del villaggio, chi sta nella reception della pensione, l’host dell’Aribnb, il cameriere del ristorante, sono i genitori che ci danno alloggio e ristoro e che si prendono cura di noi.
In vacanza, anzi, si ha la possibilità di essere serviti (e riveriti, direbbe mia nonna) e questo aumenta il piacere che lo stacco dà.
Questa estate sono stata nei Paesi Baltici, in un viaggio itinerante nelle tre capitali, ma anche nelle bellissime località costiere, isolane e contadine che questi Paesi offrono e sono stata benissimo.
Cibo ottimo, letti comodissimi, pulizia, ordine, tranquillità e quiete uniti a vivacità, movimento e sensazione di progresso.
Cosa si vuole di più da un luogo, da un paese?
Non abbiamo mai trovato degrado. Abbiamo incontrato povertà, soprattutto nelle periferie ex sovietiche dove è chiaro che non ci sono i soldi per riparare niente e le case sono tutte storte e consumate dal tempo, ma degrado mai.
Non abbiamo incontrato disagio, perlomeno apparente ai nostri occhi.
Ci sono molti venditori di fiori e di frutta che, evidentemente, chiedono la carità dell’acquisto per potere sopravvivere, ma lo fanno operosamente e dignitosamente.
I Paesi Baltici sono denominati tigri proprio per lo scatto di sviluppo che stanno vivendo (Pil in forte crescita e debito pubblico molto basso) e questa aria si respira quasi dappertutto.
I giovani, molto molto giovani, lavorano ovunque, con facilità e questo ti fa sentire circondato da impeti ed entusiasmi che galvanizzano.
I turisti sono trattati con moderazione, non con il calore che contraddistingue i popoli del Mediterraneo, ma è tutto organizzato in modo che funzioni, dai mezzi pubblici ai servizi di tutti i generi.
Insomma, nei quindici giorni in cui ho staccato, non solo ho potuto conoscere terre e popoli diversi, sono anche riuscita a prendere una boccata d’aria di educazione civica e di voglia di crescere che, in Italia, non stiamo più respirando da tempo.
Perché non provare a cambiare atteggiamento? Basta polemiche, lamenti, accuse, minacce e basta pensare solo a sé e ai propri interessi. Curare la cosa pubblica, contribuendo in modo personale nel rispetto di leggi rispettose fa stare bene, molto bene.
L’unica sera in cui non riuscivamo a prender sonno perché sotto casa c’erano persone che parlavano ad alta voce pur essendo orario notturno, parlavano in italiano.
Perché non possiamo cambiare (e progredire) anche noi?