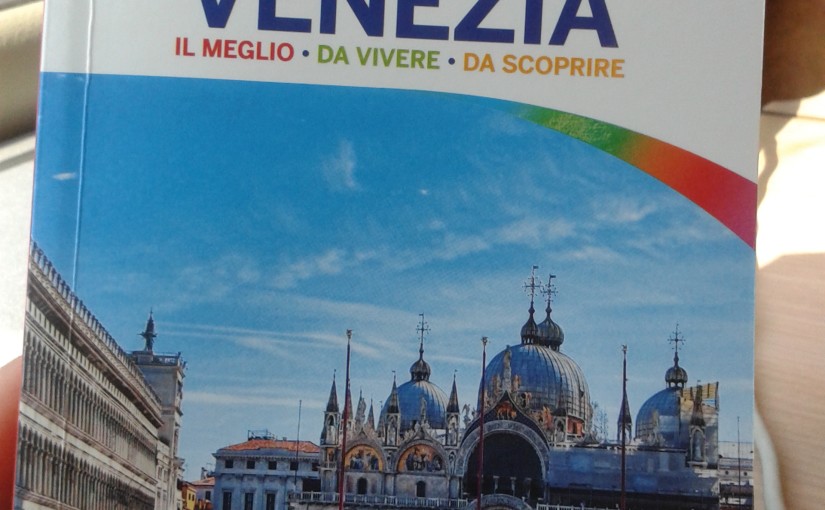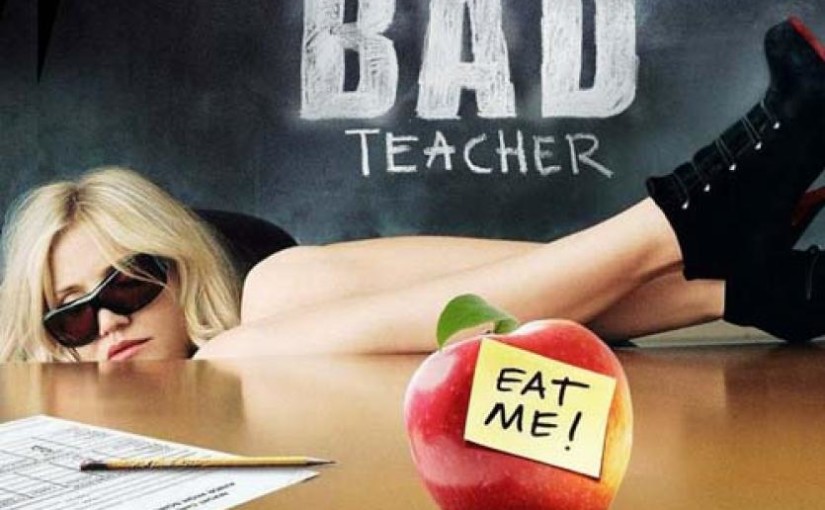Non bisogna capire questo film, bisogna crederci.
Bisogna credere che i cattivi perdano, che gli innamorati non si debbano dividere, che gli amici ti possano proteggere e sostenere nelle imprese impossibili e che la sorte del mondo sia nelle mani dei più umili.
Bisogna credere che un bagno si possa riempire d’acqua come se fosse una piscina, bisogna credere ai miracoli, bisogna credere alle rivoluzioni, bisogna credere alle favole.
Cercare di capirlo significa entrare nei mille simboli presenti che lo rendono molto più ermetico di quanto possa sembrare, camuffato com’è di immagini che lo fanno assomigliare ad un cartone animato e, invece, è la Cabala.
Le uova, il sangue, le dita di una mano, la sveglia, il telefono, il corridoio, i gatti, il sale, le cicatrici, la gelatina verde, la danza, le torte, la notte, il canale, l’acqua.
Alla fine lo analizzi, ma mentre sei dentro nuoti e basta, sommerso dalle immagini e dalla straordinaria recitazione di Sally Hawkins, che, leggiadra, attraversa la trama come se fosse un sogno.
La forma dell’acqua è un viaggio attraverso il sentimento, è un’opera imperfetta nella quale tuffarsi per farsi portare via, verso il mare, è un film sulla libertà di essere e di amare chi vogliamo.
La forma dell’acqua è un film proprio sulla possibilità di trasformare e di trasformarsi, a patto che si permetta alle nostre cicatrici di venire curate (e guarite) da chi ci ama.
Fare i conti
Fare i conti con le proprie debolezze è tremendo. Se li si fa davvero.
Se si è sinceri, se si lasciano parlare tutte le emozioni che pulsano sotto, se ci si accorge delle invidie, delle gelosie, delle rabbie, dei fastidi che si provano, se si lascia uscire tutto ciò e si sente al contempo consapevolezza, è terribile.
Il fatto di rendersene conto rende tutto difficile e doloroso perché la frustrazione è doppia, la mortificazione doppia, il disagio doppio.
Io sono tutte quelle cose brutte e, contemporaneamente, so di esserlo.
Ci si abbatte, ci si scoraggia, si diventa come se tutto fosse quella cosa orribile che provo dentro di me.
Non vorrei, ma sono così.
Nessuno mi amerà più, a partire da me.
Sono, però, sicura, che sia il solo modo per venirne fuori.
Se io so che sono così, se io me ne accorgo, se tocco con mano e vedo cosa mi succede, io sono già altro da ciò che mi succede, io sono già fuori da ciò che mi succede.
La me che vede ciò che è scomodo, doloroso, non bello, si strugge, si dispera, si vergogna, si delude, ma è quella me che può decidere, quindi, di essere altro.
Se capisco che sono io, solo io e non altri a determinare il mio stato d’animo, posso essere io, solo io, e non altri, a cambiarlo.
Oggi, in più, ho capito che l’obiettivo non è, però, “diventare capaci di non essere più ciò che non ci piace”, giurandoci che “la prossima volta non succederà”.
Succederà ancora, una, dieci, cento, mille altre volte.
Quello che possiamo fare è imparare ad uscire ed entrare in continuazione dalle aree di noi che meno ci soddisfano, perdonandoci e accettandolo con benevolenza e tenerezza.
Così da sapere perdonare e accettare con benevolenza e tenerezza anche gli altri.
I disegni sui vetri
Un giorno di tanti anni fa, mentre mi raccontava della sua infanzia con un entusiasmo, mia mamma mi parlò di una cosa bellissima che faceva quando era inverno.
Nella registrazione che ero riuscita a realizzare, ho trovato le sue parole: “… mi ricordo della neve che veniva grossissima” diceva “… e poi mi ricordo dei vetri, che c’erano tutti come dei vetri come se fossero dei grandi disegni… c’era il gelo e sai che sui vetri, noi dentro, col nostro respiro li facevamo appannare e si vedeva dei bei disegni che io mi ricordo che una volta ho preso uno spunto e a scuola ho fatto questa greca perché erano così belli che dai vetri vedevo queste cose di natura fatte così… “.
Le attività del tempo libero di quell’infanzia non potevano fare riferimento non solo a quella che oggi chiamiamo tecnologia, ma nemmeno alla quantità di giocattoli, giochi da tavolo, libri per l’infanzia e giornali che divenne il patrimonio a disposizione durante il successivo florido periodo degli anni Sessanta.
I bambini non avevano che la propria fantasia, gli oggetti della vita quotidiana e la natura.
Sarebbe facile considerare quel periodo migliore e questo, invece congestionato da stimoli plurimi, tecnologici, appunto, e confusi, un peggioramento della qualità della vita, ma sicuramente occorre riflettere sulle conseguenze che ha questo cambiamento sulla crescita dell’uomo.
Occorre approfondire quali sono le differenze tra crescere in un modo e crescere in un altro, anche alla luce del fatto che la natura dell’uomo, nel suo corpo e nel suo spirito, invece, non credo si sia modificata così tanto.
Le sue caratteristiche più profonde, i suoi bisogni, le sue aspirazioni non possono essere cambiate quanto lo sono le condizioni in cui viviamo.
Certo, le due cose si condizionano a vicenda, ma, sicuramente, viaggiano a due velocità.
I bambini piccoli, anche oggi, nel gioco, preferiscono il materiale spontaneo che li circonda e che arriva dalle pratiche di tutti i giorni del resto della famiglia. Un po’ perché condiviso (e non è poco) e un po’ perché più capace di essere manipolato.
Un cucchiaio, una corda, il coperchio di una pentola oppure un mazzo di chiavi sono interessanti, ai loro occhi, proprio perché con questi oggetti da esplorare, possono fare quello che vogliono.
Possiamo fare quello che vogliamo anche con uno smartphone?
Forse possiamo fare quello che vogliamo sui binari che quello strumento ci indica, ma molta meno in libertà di quanto si possa credere.
Ci guidano le immagini, c’è una interazione, ci affascina la velocità, insomma, non siamo soli nel governare quel gioco e, per questo ci piace, ma il rischio è che tutto si fermi lì.
L’immaginazione, da sempre si sa, è il motore per creare il mondo, apre all’infinito e lascia completamente liberi di andare dove ci pare e nei giochi interattivi sul tablet non mi sembra che questo accada.
Si va dove il meccanismo ci porta.
Sono la prima a sperare che in qualsiasi attività umana l’uomo possa rimanere uomo e che il suo apporto riesca a governare ciò che accade, ma temo si stia sottovalutando il pericolo richiamato da Galimberti (1999) del predominio della tecnica che, da strumento a nostra disposizione, diventa ambiente che ci circonda e che ci costituisce.
“La tecnica – lui dice – è il luogo della razionalità assoluta, in cui non c’è spazio per le passioni o le pulsioni, è quindi il luogo specifico in cui la funzionalità e l’organizzazione guidano l’azione”.
“La tecnica – prosegue – non tende ad uno scopo, non promuove un senso, non apre scenari di salvezza, non redime, non svela verità, funziona e basta”.
L’argomento non è nuovo, il dibattito nemmeno ed è interessante.
Io lo ripropongo solo perché non si perda occasione di cercare di comprendere verso dove stiamo andando.
A meno che ci basti la voce del navigatore che, ad ogni nostro errore, ricalcola il percorso da fare senza prendere in considerazione l’ipotesi che noi si abbia cambiato idea.
Vergogna e paura
Leggo sui media di femminicidi tutti i giorni, uno perché se ne parla molto e due perché sono frequenti, purtroppo.
Leggo, mi indigno, provo paura, rabbia, vergogna per l’essere umano, maschile.
Leggo, provo dispiacere, quasi incredulità perché ciò che avviene possa avvenire.
Poi, un giorno qualunque di una settimana qualunque, nel centro storico di una bella città toscana sul mare, mi imbatto nella violenza, in quella violenza.
Aspetto fuori da una gelateria mio marito che si compra un cono, immersa nella mia normalità, fatta anche di dissapori proprio perché normale, quando la scena che fino a quel momento era in secondo piano rispetto ai miei pensieri diventa improvvisamente quella di un film, a grande schermo.
Un uomo, di spalle rispetto a me, parla sottovoce tenendosi molto vicino al volto di quella che potrebbe essere la sua fidanzata/moglie/compagna.
Lei, che io vedo e sento molto bene, grida di lasciarla in pace. Una volta, due volte, dieci volte.
Più lei grida e indietreggia, più lui le si fa sotto, continuando a parlare sottovoce, senza lasciarla.
La strattona.
La spinge.
Lei tenta di divincolarsi, ma non riesce.
Lui è silenzioso, ma feroce.
Lei tenta di scappare, lui la ferma.
Io sono terrorizzata, ma non faccio in tempo ad avvicinarmi perché, in meno di un minuto si svolge tutto.
L’epilogo è drammatico, sottilmente drammatico e mi sconvolge.
Lui le sequestra la borsa e la borsetta e se ne va.
Lei è attonita, deprivata, derubata, sequestrata a sua volta, senza più effetti personali, né documenti.
Lo segue, rimanendo sul lato opposto della strada.
Camminano, ma, ad un certo punto, lei decide di darsela a gambe lo stesso.
E inizia a correre, corre, corre, sempre più veloce.
Lui svolta un angolo, pieno di sé e del bottino sotto il braccio, convinto di averla in pugno.
Lei sparisce all’orizzonte, spero per sempre.
Sono passati tre giorni e stanotte ho fatto un sogno bruttissimo.
Mi inseguivano, mi picchiavano, io scappavo e picchiavo a mia volta.
I soggetti erano mostri. Come quello dell’altro giorno.
La violenza non si misura a lividi e ferite sulla pelle, la violenza è tanto maggiore quanto violenta l’anima, quando ti toglie la libertà, quando si insinua talmente a fondo da tornare a visitarti di notte, anche se ne sei solo testimone.
Quella violenza è da raccontare, per combatterla, ma, soprattutto, per rendere pubblico ciò che, apparentemente, è affare privato e, peggio ancora, affare normale.
Coraggio e solidarietà a tutte le persone che stanno subendola e un augurio che ce la facciano a dirlo a qualcuno, primo passo per trovare o ritrovare la libertà.
Le due donne
Due simpatiche donne over sixty parlano amichevolmente al tavolo del bar sulla spiaggia.
Lido di Venezia, ventisei gradi, piacevolissimo pomeriggio di una perfetta domenica di giugno.
Un venticello leggero accarezza le confidenze tra le coetanee.
Argomento: la tecnologia.
Entrambe la usano, parlano di smartphone, di tablet e di connessione, dimostrando di avere risposto al richiamo dei nuovi mezzi, ma non fanno parte di questo mondo, si sente, lo usano e basta.
Ci provano, diciamo.
Una di loro ha appena “fatto funzionare Whatsapp” e ne decanta con soddisfazione i risultati.
“Pensa, mio nipote è in Cile e ieri ci siamo parlati tutta la sera!”
L’amica (senza whatsapp) le chiede se “hanno usato le parole o la scrittura”.
Lei risponde che suo nipote “usa anche la voce”, mentre lei, che non è capace, solo “le parole scritte”.
“Ma, non è piccolo lo smartphone?” le chiede, allora, l’altra.
“NOO, guarda come si fa!”
“Davvero, hai ragione, è abbastanza grande… non fugge via!”
Meravigliose.
Il breve dialogo mi porta in un posto lontano, quando c’erano altri oggetti e altre parole.
Mi porta nel passato e il passato è seduto accanto a me.
Le cose nuove hanno corso più degli anni sui quali viaggiavano.
Chi ne ha sessanta ha visto il mondo trasformarsi mentre cresceva e il ponte che collega i propri genitori, spesso ancora vivi, ai propri figli si è fatto talmente lungo che non si vede più il punto di partenza.
C’è poco da avere nostalgia.
Parlarsi da un capo all’altro del mondo con facilità e quasi gratuitamente è fantastico.
Trovare informazioni velocemente da casa, anche.
Per chi ama scrivere, è un’epoca d’oro, di condivisione allargata e di opportunità.
L’impressione che ho, però, è quella di una navigazione a vista, e sempre in mare aperto.
La rotta mi sfugge, il capitano non lo vedo.
Ognuno ha la sua barca, molti la condividono con centinaia di persone e non hanno acqua, né viveri.
Il traffico è intenso.
Qui, al tavolo del bar, ascolto le due donne e le vedo a riva, che guardano l’orizzonte in cerca di battelli.
Forse, sono anch’io sulla terra ferma, ad aspettare di partire, forse esco a pesca tutte le notti e, poi, ritorno a casa.
Mi piace ancora guardare le cartine geografiche e spedisco cartoline.
Instagram e Twitter mi divertono, ma non voglio pubblicare mie foto o foto di chi mi sta vicino.
Non sono una nativa digitale e me ne vanto.
La mia infanzia è in bianco e nero e la considero una cosa preziosa, perché era bella e non c’è più.
Sono affezionata a tutto ciò che è stato e ricordarlo mi emoziona.
So da dove sono partita e cosa mi piace del viaggio.
Nonostante ciò, spesso perdo la strada ed è per questo che penso a quanto sia importante avere la mappa con sé.
E la voce delle mie vicine, in questo fresco pomeriggio di sole, è un punto che, con il pennarello, segno sulla mia.
Bad Teacher
Il film americano del 2011, dal titolo “Bad Teacher” (Una cattiva maestra), con Cameron Diaz e Justin Timberlake, è uno degli esempi di rappresentazione artistica più adeguati a indicare le diversità culturali tra gli Stati Uniti d’America e l’Italia.
La pellicola tratta di un’insegnante di Scuola Media (Secondaria di Primo Grado non si può sentire) il cui personaggio è disegnato nei minimi particolari perché sia il massimo esempio di negatività che un riferimento educativo possa essere.
Si droga, beve, mente, imbroglia, corrompe, dorme in classe, mortifica gli studenti, si prostituisce e antepone i personali interessi a quelli dei suoi allievi.
Se si aggiunge che i personali interessi corrispondono a rifarsi il seno per conquistare, senza amore, un ricco collega, il quadro è completo.
L’esagerazione del dipinto, comprese le battute e le scene esplicite a sfondo sessuale, volgerebbe a fare ridere, ma non si ride.
È questo il punto: tutto ciò che è pensato per essere comico, a noi risulta grottesco e fuori luogo.
Non solo perché tocca il tabù dell’educazione dei più piccoli (coinvolti scenograficamente e realmente in questo volgare racconto), anche perché infrange, e senza appelli, una dopo l’altra, tutte le regole della buona vita (tranne che nel finale in cui, miracolosamente, per potere chiudere, Cameron Diaz ritorna ad essere normale).
Ciò che dovrebbe divertire, invece, urta e infastidisce.
Tra noi e loro, in sostanza, di diverso, c’è la sensibilità.
La sensibilità, da vocabolario, è la “particolare attitudine a risentire gli effetti, anche più insignificanti, di una condizione affettiva o emotiva”, oppure, ancora, è “l’intensità e l’acutezza con cui un soggetto intuisce col pensiero qualcosa di esterno da lui” o, anche, è “la disposizione di condividere un’emozione provata da soggetti altri da sé”.
La sensibilità, in altre parole, è la maturità.
Cognitiva ed emotiva.
E non la si acquisisce studiando, s’impara attraverso l’esempio, l’esperienza e la riflessione.
Ed è proprio in questo che siamo diversi.
Secoli e secoli di esperienza personale, sociale, artistica e, non da ultimo, politica, ci rendono maggiormente sensibili e, quindi, più difficili da accontentare. Più capaci di sentire cosa c’è dietro alle cose.
Ovviamente, la tendenza alla superficialità o all’approfondimento, esistono da loro come da noi e appartengono anche alla condizione personale, non si può generalizzare, ma, nel cinema ci sono, come in questo caso, esempi chiari in cui non-ridere-per-le-stesse- cose rende l’idea.
Il tipo di comicità dipende dallo sfondo culturale nelle quali le figure individuali vivono e rendersi conto degli sfondi può aiutarci a comprendere meglio noi stessi e gli altri.
In quanto, ognuno, piccolo elemento di un sistema complesso.
E aiutandoci a spostare l’accento da quanto-siamo-diversi a in-cosa-siamo- diversi, ci permetterebbe anche di sentirci un po’ meno protagonisti e un po’ di più parte di un universo più grande di noi.
Per potere poi, perché no, riderci sopra insieme.
La memoria e il cuore
Non scrivo qui da più di un mese.
In questo mese è morto mio papà e non c’è nulla di più personale che dare questa notizia, che scrivere di questo in questo blog.
Eppure, lo devo fare, altrimenti non continuo.
Tutto ciò che era prima, ora non è più.
Tutto il mondo di prima è un altro mondo, oggi.
Tutta la vita, è un’altra vita.
Questo scritto lo dedico a chi ha già vissuto questo dolore, ma anche a chi lo non lo conosce ancora, perché è uno scritto che dedico alla vita e alla morte, insieme.
Le due cose non sono divisibili, ora lo so, anche se una delle due rimane sempre in ombra, perlomeno nella nostra cultura.
Io, alla morte dei miei genitori, ho pensato cento, mille, un milione di volte, ma ciò in cui il mio pensiero si traduceva immediatamente, impedendomi di sentire altro, era la paura.
E, incredibilmente, la paura, quando è successo per davvero, è stata l’unica cosa che non ho provato.
Ho sentito il senso crudo di realtà che in poche occasioni capita di vivere, ho vissuto lo scorrere preciso di pensieri e di azioni che capitano quando è necessario fare fronte ad un evento più grande di noi.
Ho provato la sequenza forte di momenti unici e importanti che rimarranno impressi per sempre nella mia memoria e nella memoria di chi li ha condivisi con me.
È vero che conta non essere soli, ma non solo nel senso di avere persone che ti esprimono vicinanza, soprattutto nel senso di provare quella cosa lì insieme ad altri che provano proprio quella cosa lì.
È un unico dolore che viene diviso in più parti e ce la fai se lo condividi perché diventa più leggero, diventa possibile da vivere.
Poi, a riflettori spenti, quando ognuno torna a casa, ciò che ti cade addosso è un macigno che non riesci ad evitare.
Arrivano onde anomale di dolore che ti sommergono senza preavviso. In un momento sei serena, mangi, guardi la televisione e nel momento dopo sei morta anche tu, seppellita da una mancanza e da un vuoto che non si possono descrivere.
Mio papà, come tutti i papà, è nel mio sangue, nella mia pelle, nei miei muscoli, nei miei occhi, nel mio cuore.
Mio papà, come tutti i papà belli e buoni, è anche nella mia anima, come uno specchio nel quale mi rifletto.
Mio papà è nella mia storia, le mie azioni sono state condizionate dalle sue, prima nella dipendenza da lui, poi nella libertà che ho conquistato lottando contro di lui ed, infine, nella straordinaria possibilità di occuparmi di lui con tenerezza.
Ciò che, oggi, posso dire di non avere perso è la sensazione di amore che ha riempito gli ultimi anni della nostra vita insieme.
Sempre, l’ho amato, ma durante la sua vecchiaia, questo amore è esploso, senza più fatiche.
“Sei come la mia mamma” una sera di un anno fa mi ha detto e io non solo lo ricorderò per sempre, so di essere anche diventata quella frase lì.
Io sono anche ciò che sono stata con lui e questo non muore.
Tutti coloro che credono, me compresa, mi consolano con parole che invitano a pensarlo felice e spiritualmente vivo.
Ciò che accade, ora, però, è qualcosa di più umano, di più terreno, ovvero il senso della morte che sta insieme al desiderio di vivere ancora.
Di rinascere, di ritornare alla vita leggera, quella delle mattine di vento al mare, dei pranzi di festa con il buon cibo, dei viaggi intensi a visitare il mondo, del riposo dopo il lavoro, della luce del lago in primavera.
Ora, ciò che riempie le mie giornate è la convivenza tra il disperato bisogno di sentire ancora la sua voce e la necessità fisica di proseguire senza tristezza, nonostante la sua voce non ci sia più.
Non è la teoria, ciò che sento oggi, è la pratica intensa delle ore che continuano in cui, a poco a poco, la vita ritorna in primo piano, dopo giorni in cui era diventata un film sullo sfondo.
Non so cosa è più giusto fare in questi incredibili momenti, ma di sicuro so cosa sta facendo bene a me e ciò che mi sta facendo bene è il darmi la possibilità di esprimermi, trovando in libertà tutte le possibilità che riesco a trovare.
Come voglio, con chi voglio e quando voglio.
Non so se mio papà mi ha insegnato questo, forse l’ho imparato io.
Lui mi ha chiamata in questo mondo e mi ha lasciato ciò che è stato.
Io posso proseguire nel mio cammino, che è stato anche il suo e che è quello del mondo.
Le ultime parole che gli ho sussurrato prima di vederlo sparire per sempre sono state “arrivederci papà”.
La morte, adesso, mi fa meno paura di prima, perché l’ho conosciuta.
Grazie papà, da un fifone come eri a una fifona come sono io, questo è un regalo meraviglioso.
Ciao Cino Tortorella
Tutte le persone che hanno la mia età non possono non ricordare il Mago Zurlì.
Si chiamava Cino Tortorella, ma, in realtà, era Mago Zurlì.
Ed esisteva davvero.
Con la sua gentilezza ha conquistato migliaia di bambini e la sua presenza leggera era talmente delicata da sembrare una nuvola.
Azzurra.
Io l’ho conosciuto di persona, in uno spettacolo al Teatro Angelicum di Milano.
Sono salita sul palco e ho cantato “Viva la pappa col pomodoro”.
Lui mi ha fatto qualche domanda e, alla fine, mi ha riempito la borsetta di caramelle.
Anni dopo, questa borsetta, che mi ricordavo gigantesca, mi è riapparsa tra le mani minuscola come quella di una bambola.
Oggi, Mago Zurlì è morto e con lui è morto un pezzo di quella storia, già addormentata da secoli.
L’infanzia, anche se non c’è più, rimane sullo sfondo come un film.
Riemerge a tratti e, più passa il tempo, più ti commuovi quando arriva.
L’infanzia, più passa il tempo e più ritorna, come nei vecchi, che riavvolgono il nastro e, alla fine, per ultimo, rimane il primo momento.
Ciao Cino Tortorella, ciao ai tuoi novant’anni, ciao ai tuoi capelli da Principe, perché più che un Mago eri un Principe, ciao alla tua improbabile calzamaglia e alla tua voce così paziente da farti sembrare sempre confuso.
Ciao, anzi arrivederci, Cino Tortorella.
Non ci resta che piangere
Ovvio, ovvio che non esiste sparare ad un’altra persona, magari alle spalle, nemmeno se sei arrabbiato o spaventato perché qualcuno è entrato in casa tua per rubare.
Ovvio.
Ovvio che non esiste dire che non dispiace la morte di un uomo e che chi ha ucciso ha fatto bene.
Ovvio.
Ovvio che non ci si difende da sé come accadeva mille e più anni fa.
Ovvio.
Tutti lo sanno, anche chi si ostina a dichiarare il contrario.
E tutti sanno che chi si fa fotografare accanto al signor Mario per fare campagna politica è una persona furba.
Ma io non riesco ad accettare la diatriba che si innesta questa vicenda.
Non riesco ad accettare che la questione diventi chi ha maggior torto, quando, di fronte ad una morte, non ci sono graduatorie che tengano.
Una morte è una morte, un furto un furto.
Ma perché, perché ci scateniamo gli uni contro gli altri e non ammettiamo, invece, che siamo tutti coinvolti in questa scena in cui non ci sono vincitori, ma soltanto perdenti, poveracci e perdenti?
Dovremmo tacere, e pregare, per chi non c’è più e per chi ha perso l’anima.
Dovremmo stare zitti e vergognarci di quanto è successo e di quanto sta succedendo, nei fatti e nelle parole.
Dovremmo mortificarci, non discutere.
Abbracciarci, non litigare.
Dovremmo confessare di avere oltrepassato i limiti, chiedere perdono a noi stessi, prima ancora che agli altri.
Quale è la via per ritornare in sé?
Per ritrovare le ragioni e la dignità?
Parlare? Parlarsi?
Certamente fermarsi. A riflettere, per cercare di capire cosa sta accadendo.
Non è in gioco il concetto di giustizia, ma, più profondamente, la questione della vita e della morte.
Ed è su questi temi che occorre discutere confrontarsi, non sulla legittima difesa.
Riprendere il filo, ritrovare il bandolo.
Altrimenti, dopo avere eliminato il ladro e condannato l’assassino, non ci resterà altro che piangere.
A casa
A casa, apparentemente senza stimoli, né cose da scrivere.
Eppure, il mondo gira dentro, anche se sei ferma.
Desiderio di cose nuove, come la primavera, che arriva sempre, incredibilmente pronta.
La nostalgia delle cose passate si stempera un po’ lasciando spazio al respiro.
Il mare è lontano, ma, come il mondo, si muove dentro, anche lui.
È nella testa, con la sua immagine chiara, provvista di audio e di odori.
L’aria sulla faccia, le voci distanti e leggere, nel naso la Liguria, che arriva improvvisa appena scendi dalla macchina.
Le cose ci sono anche se non le vedi, ma è la testa a farle arrivare.
Lodiamo sempre il cuore, lo incoroniamo re della nostra anima, ma senza la testa non siamo niente.
È una scoperta di questo tempo, forse mi unisce a ciò che credevo fosse unico e, invece, come tutto, non è niente da solo.
Siamo mille cose che non sappiamo e una cosa sola che è l’adesso.
E tutto il resto, come diceva Ruggeri, è un’ipotesi.